
SCUOLA MEDIA “ MARIA
IMMACOLATA”
ISTITUTO S.AGNESE SARONNO
MARIO
RONCORONI




CLASSE 3A MEDIA
SEZIONE B
ANNO SCOLASTICO 2001/2002
L’energia è una grandezza fisica e viene definita come la capacità di un corpo di compiere un lavoro, ovvero di spostare un corpo. Infatti , con il termine lavoro non si indica un’attività generica bensì lo spostamento di un corpo da un punto ad un altro grazie a una forza ad esso applicata.
Il concetto di lavoro è ,
infatti legato al movimento: non c’è lavoro se non c’è spostamento. Per
misurare l’energia impiegata è necessario conoscere il lavoro compiuto.
Il lavoro è quindi dato dal
prodotto della forza impiegata per lo spostamento avvenuto nella direzione della
forza:
lavoro
= forza x
spostamento
La capacità di compiere
un lavoro corrisponde all’energia che il corpo stesso può sviluppare; tale
energia può essere di due tipi: potenziale e cinetica.
Il sasso tenuto in mano ad una
certa altezza dal suolo non compie nessun lavoro, ma se cadesse sull’estremità
di un’asse, sarebbe in grado di far saltare in aria il libro posto
sull’altra estremità.
Il sasso ha quindi in sé la
capacità di compiere un lavoro, cioè energia. Tale energia gli deriva dalla
posizione che ha e non viene sfruttata finché il sasso non cade. Si può dire
quindi che il sasso possiede un’energia potenziale o di posizione.
Quando si lascia cadere il
sasso, questo, precipitando sull’asse, compie un lavoro in quanto il movimento
di caduta gli dà l’energia necessaria. Diciamo quindi che esso possiede
un’energia cinetica o di movimento.
L’energia potenziale è
quindi l’energia posseduta da un corpo in quiete e dipende dalla sua
posizione.
Un sasso posto in bilico sopra
a un muro, l’elastico di una fionda, una molla schiacciata o l’acqua
trattenuta in una diga possiedono energia potenziale.
L’energia cinetica è
l’energia che ha un corpo in movimento e dipende quindi dalla sua velocità.
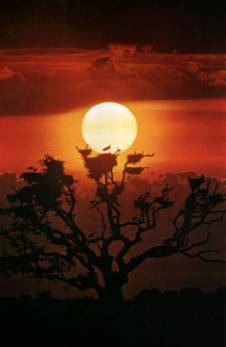 Un’automobile
in corsa, il vento che soffia, l’acqua che precipita a valle, la molla che
scatta possiedono energia cinetica.
Un’automobile
in corsa, il vento che soffia, l’acqua che precipita a valle, la molla che
scatta possiedono energia cinetica.
L’energia potenziale e
cinetica sono due aspetti dell’energia meccanica, ma esistono altre forme
sotto cui si manifesta l’energia, intesa come capacità di compiere un lavoro
: energia muscolare, energia eolica, energia idrica, energia chimica, energia
elettrica, energia termica, energia nucleare.
La maggior parte dell’energia
esistente sulla terra è dovuta all’energia del sole che arriva sotto forma di
energia luminosa ed energia termica. L’energia del sole è detta fonte
primaria d’energia perché non deriva da altre fonti d’energia.
La principale fonte di energia
utilizzata dall’uomo nell’antichità fu quella muscolare umana e animale,
infatti, per molto tempo gran parte del lavoro fu svolto dagli animali domestici
e da schiavi. Ma già’ allora l’uomo seppe sfruttare altre forme di energia:
la legna fornì il calore necessario per scaldarsi, cucinare e lavorare i
metalli, l’energia del vento rese possibile viaggiare con navi a vela.
Col tempo l’uomo imparò a
costruirsi attrezzi e macchine che migliorarono il rapporto tra energia spesa e
risultato ottenuto: la leva , la carrucola, ecc.
Durante il medioevo e il
rinascimento si ha una svolta nel rapporto tra energia ed attività umane.
L’aumento dei traffici determina la specializzazione delle produzioni e
un miglioramento delle condizioni generali. L’impiego del mulino ad acqua sarà
determinante per lo sviluppo di settori quale quello tesile e siderurgico.
La vera rivoluzione del modello
di utilizzo delle fonti d’energia si ha con l’invenzione della macchina a
vapore, che permetterà la trasformazione dell’energia termica in energia
meccanica. È proprio questa scoperta che segnerà l’inizio della nuova
produzione industriale e della diversa organizzazione del lavoro, che tenderà
sempre più a concentrarsi nella fabbrica. La macchina a vapore, nel campo dei
trasporti pose le basi per la grande espansione di traffici e commerci.
L’era del petrolio inizia
solo alla fine dell’ottocento con la scoperta del motore a combustione interna
alimentato a benzina. La diffusione del motore a scoppio determinò il rapido
declino della macchina a vapore e il forte impulso per la ricerca dei
combustibili liquidi derivanti dal petrolio, fonte fino allora trascurata e che
divenne di primaria importanza.
Sempre nella seconda metà
dell’ottocento si conosce una nuova fonte di energia, grazie alle scoperte
sull’elettricità e alla messa a punto di tecniche per la produzione
d’energia elettrica. Verso la fine del secolo con l’invenzione delle turbine
e degli alternatori si costruiscono le prime centrali elettriche e presto
l’energia fu utilizzata per tantissimi usi domestici ed industriali. Questa
fonte di energia ha il vantaggio di potere essere trasportata anche a grandi
distanze e ciò ha consentito lo sviluppo di nuovi impianti e nuove tecnologie
nei più svariati settori industriali.
Infine nei primi decenni del
novecento viene scoperta l’energia atomica, il primo reattore nucleare fu
messo a punto nel 1942 a Chicago dal fisico Enrico Fermi e dai suoi
collaboratori. Le prime applicazioni dell’energia nucleare furono militari ma
negli anni seguenti si sviluppò anche la ricerca per impieghi pacifici.
Tutto ciò che, con opportuni
procedimenti, può fornire energia con cui produrre lavoro è detto fonte di
energia.
Fonte primaria d’energia è
il sole, ma sono fonti di energia anche i combustibili fossili, l’acqua , il
vento, il calore interno della terra, il mare e la biomassa.
Le fonti energetiche si possono
suddividere in fonti non rinnovabili e rinnovabili.
Quelle non rinnovabili sono
presenti in natura in grandissima quantità, sono soggette alla massiccia
utilizzazione da parte dell’uomo e quindi sono destinate ad esaurirsi. Le
fonti più sfruttate sono : legno carbone, metano, petrolio, uranio.
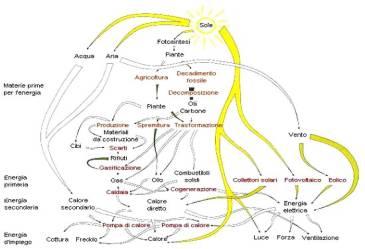 Le
fonti energetiche rinnovabili sono legate ad elementi naturali: acqua ,vento,
sole ecc, e in quanto tali sono inesauribili.
Le
fonti energetiche rinnovabili sono legate ad elementi naturali: acqua ,vento,
sole ecc, e in quanto tali sono inesauribili.
Energia geotermica
Manifestazione dei fenomeni interni alla superficie terrestre in forma di
calore, eventualmente convertibile in altre forme di energia, direttamente
utilizzabili dall’uomo. All’inizio degli anni Settanta, in coincidenza con
la crisi petrolifera, e negli anni seguenti, a causa dei vari insuccessi degli
impianti di produzione di energia nucleare, la possibilità di generare energia
elettrica sfruttando il calore interno della Terra sembrava uno dei metodi più
promettenti fra le cosiddette fonti energetiche alternative. La realizzazione
pratica del principio, però, si è mostrata meno immediata e conveniente di
quanto creduto, e oggi si tende piuttosto a considerare l’energia geotermica
come una fonte integrativa di energia: non in grado di rimpiazzare del tutto
altre fonti, ma comunque molto conveniente in alcune situazioni e soprattutto
assai sicura dal punto di vista ambientale.
La presenza di manifestazioni
geotermiche era già nota agli Etruschi e ai Romani; tracce di acido borico sono
state rinvenute negli smalti usati per la decorazione di ceramiche etrusche,
mentre dal Medioevo è documentato l’utilizzo dei minerali deposti da soffioni
e lagoni per la coloritura dei tessuti e la preparazione di medicinali. Nel 1777
il chimico tedesco Franz Höfer, direttore delle spezierie granducali, scoprì
nelle acque fangose dei lagoni la presenza di acido borico, di cui si iniziò a
studiare la possibilità di utilizzo nell’industria (saldatura, invetriatura
delle ceramiche) e in farmacia.
Nel 1818 la ditta Larderel,
fondata da François-Jacques de Larderel, impiantò presso Montecèrboli una
fabbrica per lo sfruttamento su vasta scala delle acque boriche. Nello stesso
periodo de Larderel iniziò la perforazione dei primi pozzi per aumentare la
produzione di acqua e vapore, e poco dopo ebbe l’idea geniale di utilizzare lo
stesso vapore naturale per riscaldare le caldaie in cui avveniva la
concentrazione della soluzione borica. Il vapore veniva captato per mezzo di un
duomo in muratura, chiamato “lagone coperto”, costruito sopra le
manifestazioni naturali e quindi convogliato alle caldaie di concentrazione. In
riconoscimento della sua opera, nel 1846 il granduca Leopoldo II imponeva allo
stabilimento il nome di Larderello.
Nel 1904 il conte Ginori
sperimentò l’utilizzo delle forze endogene per la produzione di energia
elettrica; l’anno successivo entrò in funzione il primo impianto di
produzione. A partire dagli anni ’80 del Novecento è stato avviato
dall’Enel un programma di rinnovamento delle centrali su una vasta area che
arriva sino alle pendici dell’Amiata, mentre Larderello si è andato
qualificando come primario centro di ricerca sugli utilizzi, non esclusivamente
elettrici, dell’energia geotermica.
La presenza di acido borico
nella zona delle Colline Metallifere in Toscana fu scoperta verso la fine del
XVIII secolo. Nel secondo decennio dell’Ottocento si avviò lo sfruttamento
industriale della risorsa, che venne utilizzata anche per la produzione di
energia elettrica a partire dal 1904.
I campi geotermici localizzati nella fascia tirrenica della Toscana centro-meridionale sono l’esito di processi geodinamici di tipo compressivo e distensivo succedutesi negli ultimi 30 milioni di anni. Il primo pozzo geotermico, profondo pochi metri, fu perforato nel campo di Larderello nel 1832, ma solamente nel 1926 i pozzi raggiunsero il serbatoio carbonatico. Da allora sono stati esplorati centinaia di pozzi molti dei quali tuttora attivi.
Struttura interna della Terra
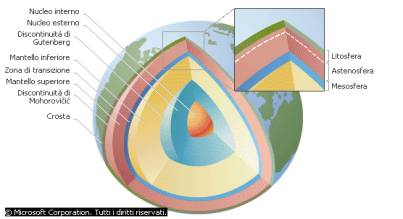
La Terra è costituita da una serie di strati di
natura chimica e fisica diversa, che si sono formati nelle prime fasi della
storia geologica del pianeta: la massa di materiale fuso originaria a poco a
poco iniziò a raffreddarsi, mentre gli elementi più pesanti cadevano per
gravità verso il centro e i più leggeri si portavano in superficie. In base ai
dati raccolti soprattutto attraverso metodi sismografici, risulta oggi che:
LA CROSTA
rappresenta lo strato più superficiale della Terra. Il suo spessore misura, in
media,35 Km. con oscillazioni minime di 4-5 Km, sotto gli oceani, e oscillazioni
massime di 70 Km., in corrispondenza delle più alte catene montuose
continentali. Nella crosta , si distinguono la crosta
continentale, cioè le terre emerse, e la costa oceanica, cioè quella parte di crosta che forma il fondo
degli oceani. La prima è molto più spessa della seconda, che è invece più
densa, più omogenea e di più recente formazioni.
IL MANTELLO Sotto la crosta terrestre, si trova, il mantello che giunge
fino ad una profondità di 2900Km ed occupa più dell’80% del volume
complessivo della Terra. Esso è separato dalla crosta terrestre dalla discontinuità di Mohorovicic, detta più semplicemente discontinuità
di Moho, in corrispondenza della quale le onde sismiche subiscono una brusca
variazione di velocità, segnalando così il passaggio a strati rocciosi
caratterizzati da maggior densità. Il mantello viene suddiviso in mantello superiore e mantello
inferiore.
Il mantello superiore presenta strati rocciosi in
parte solidi e in parte semifluidi .Il mantello inferiore, invece, è
internamente allo stato solido.
IL NUCLEO
costituisce la parte centrale della Terra; esso è una sfera interna e
concentrica al mantello con un raggio di circa 3470 Km , con un volume pari al
16% del volume del globo terrestre, posta a 2900 Km di profondità. Il nucleo è
separato dal mantello dalla discontinuità di Gutenberg, in corrispondenza della
quale si evidenzia un ulteriore aumento della densità delle rocce. Nonostante
la composizione chimica del nucleo non sia ancora del tutto certa, gli
scienziati ritengono che esso sia costituito da materiali molto pesanti come
ferro e nichel. Alla profondità di 5170 km, i dati sismici rilevano il
passaggio da un nucleo esterno liquido, a un nucleo interno solido.
L’esistenza di calore all’interno della terra è
reso evidente da fenomeni ben noti, quali i vulcani, i geysers e le fumarole,
distribuiti sulla superficie terrestre secondo fasce geografiche ben
delineate e contraddistinte dal punto di vista geologico
La
possibilità pratica di sfruttare l'enorme quantità di calore contenuta nella
terra è legata alla condizione che si concentrino in una stessa area sia la
fonte di calore, che la copertura impermeabile e che in quella zona si instauri
anche una circolazione profonda di acqua meteorica.
Si forma così un campo geotermico,
all’interno del quale si possono trovare, a seconda della temperatura e della
pressione esistenti, vapore oppure acqua, sempre accompagnati da quantità
variabili di gas e di sali minerali.
Perché
si realizzi un serbatoio ideale di energia geotermica, nel sottosuolo debbono
verificarsi alcune particolari condizioni: anzitutto la presenza, a profondità
relativamente scarsa, di una adeguata sorgente di calore, come ad esempio una
sacca di magma in via di raffreddamento. La seconda condizione è data
dall’abbondanza di acqua in formazioni rocciose permeabili a diretto contatto
con la fonte di calore: l’acqua è infatti l’indispensabile mezzo
intermediario per convogliare il calore in superficie. Terza condizione è la
presenza di un "coperchio" di rocce impermeabili che sigilli il
sistema, in modo da impedire la dispersione del calore, favorendone l’accumulo
all’interno del giacimento stesso. Attingendo alle acque del giacimento
geotermico per mezzo di pozzi, si ha un’erogazione violenta in superficie di
vapore surriscaldato che può essere impiegato direttamente per azionare turbine
di generatori elettrici. Sono questi i cosiddetti sistemi geotermici ad alta
temperatura dove in essi si possono raggiungere sono assai elevate. Il sistema
di Larderello, in Toscana, presenta temperature di 260 °C, mentre nell’area
dei Campi Flegrei, in Campania, si raggiungono addirittura i 400 °C, la più
alta temperatura finora registrata in un sistema geotermico.
La produzione
d’energia elettrica mediante questo tipo di fonte alternativa avviene in tre fasi :
studio idrogeologico e morfologico del terreno,
reperimento della fonte mediante perforazione del
bacino di contenimento,
sfruttamento dell’energia cinetica del fluido
reperito.
Agli albori della ricerca del fluido endogeno, non vi
era necessità di adottare pratiche di studio del terreno, perché la tecnologia
di perforazione non permetteva di raggiungere grandi profondità e il vapore in
queste zone fuoriusciva in modo quasi naturale e spontaneo.
Con il passare del tempo questo studio è risultato
di vitale importanza, per vari motivi fra cui i costi di realizzazione delle
opere di costruzione dei cantieri di perforazione, delle condotte di trasporto
del fluido e delle centrali geotermiche per la produzione d’energia elettrica.
La prima fase
è così affrontata:
mediante l’ausilio del satellite è stata
controllata la mappa delle temperature della crosta terrestre ( operazione effettuata una sola volta dopo
l’avvento dei satelliti ), individuando cosi le zone dove le protuberanze
magmatiche si avvicinano maggiormente alla crosta terrestre, Dopo di che lo
studio si trasferisce sul campo detto ”geotermico”
direttamente sulla zona da prendere in considerazione mediante una ricerca
effettuata da ditte specializzate, tipo la francese C & G che si avvale
della tecnologia della propagazione delle onde sismiche sul suolo, mi spiego
meglio: viene circoscritta una zona, dove si presume che vi possa essere
eventuale bacino geotermico (area d’alcuni km.²) da geofoni calati nel
terreno per mezzo di tubi che arrivano ad una profondità di circa 3 mt. Al
centro di quest’ipotetico cerchio vengono
posti dei grossi macchinari, che producono onde sismiche artificiali. Il
risultato sarà una mappatura del terreno in base alla permeabilità fonetica di
questo, che elaborandola con programmi specifici ci porta a capire la morfologia
del sottosuolo dell’area presa in esame fino a svariati metri di profondità.
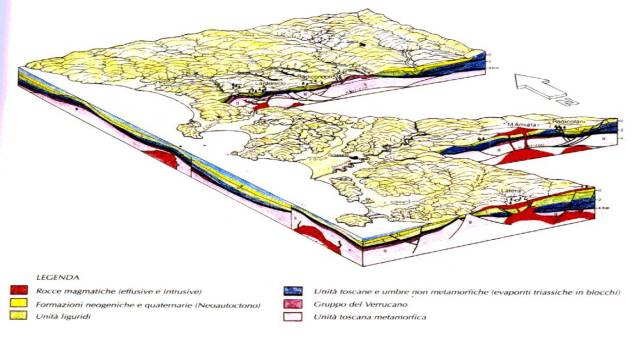
Per quanto
riguarda la seconda fase (reperimento della fonte d’energia) il procedimento è il seguente:
vengono eseguite le opere civili, riguardanti la costruzione della postazione
dove avrà luogo la perforazione del campo geotermico, costruendo il piano in
calcestruzzo, ove verrà alloggiato l’impianto di perforazione, le vasche di
contenimento dei residui della perforazione, l’area adibita alla sistemazione
dei container per accogliere il personale durante l’operazione di
perforazione.
Dopo di che viene montato il cantiere di perforazione
Ultimato il montaggio dell’impianto, viene iniziata
la perforazione il detrito che si forma durante la perforazione viene portato in
superficie mediante il fluido di perforazione (che è composto da acqua e
argilla disidratata e macinata finemente detta “bentonite”, vedi schema)e qui viene separato da macchinari
chiamati “vibrovagli”, e
accumulato in luoghi di stoccaggio per poi essere smaltito come materiale
riutilizzabile.
In fasi ben determinate il foro cosi ottenuto, è
incamiciato con tubi d’acciaio avvitati l’un con l’altro e poi ancorati
alla formazione del terreno mediante malta cementizia, con l’aumentare della
profondità, questa tubazione diviene più piccola di diametro e più grossa di
spessore tutto questo per ottemperare alle necessità delle tenute idriche,
delle resistenze meccaniche e fisico-chimiche a cui i tubi saranno sollecitati
una volta raggiunto il bacino e messo in produzione il pozzo.
Fase 3 : sfruttamento
dell’energia cinetica del fluido reperito
Una volta verificato i parametri del vapore trovato, in base a vari
analisi, che la nostra unita LABORATORIO esegue, viene iniziato l’opera di
costruzione delle tubazioni (vapordotti) per il trasporto fino alla centrale
geotermoelettrica
Sistemi
geotermici a media e bassa temperatura
Esistono anche sistemi geotermici a media o bassa temperatura (inferiore a 160
°C). Questi non possono essere sfruttati direttamente per la produzione di
energia elettrica; tuttavia il fluido geotermico naturale serve a fare evaporare
un fluido secondario a basso punto di ebollizione che a sua volta aziona i
generatori. In questi casi, però, i rendimenti finora raggiunti sono stati
piuttosto bassi. Le acque calde sotterranee possono comunque essere sfruttate
per una serie di altri usi diversi dalla produzione di elettricità. Il più
ovvio di essi è la distribuzione per il riscaldamento di alloggi o di serre di
coltivazione. In Francia, nella regione di Parigi, si sono ottenuti i migliori
risultati di questo tipo, con una rete di riscaldamento per oltre 20.000
alloggi.
Energia eolica
 Energia
eolica Espressione che letteralmente indica l'energia cinetica posseduta dai
venti, ovvero dalle masse d'aria in movimento nell'atmosfera, ma che viene
comunemente utilizzata anche per indicare l'energia, elettrica o meccanica, che
può venire prodotta da questa, dopo conversione mediante un apparecchio
opportuno. Tale energia risulta dalla forza esercitata dal vento sulle pale di
un'elica, montata su un albero rotante, che a sua volta è collegato a sistemi
meccanici, che possono servire per macinare il grano o per pompare l'acqua, o a
un aerogeneratore, che trasforma l'energia meccanica in elettrica.
Energia
eolica Espressione che letteralmente indica l'energia cinetica posseduta dai
venti, ovvero dalle masse d'aria in movimento nell'atmosfera, ma che viene
comunemente utilizzata anche per indicare l'energia, elettrica o meccanica, che
può venire prodotta da questa, dopo conversione mediante un apparecchio
opportuno. Tale energia risulta dalla forza esercitata dal vento sulle pale di
un'elica, montata su un albero rotante, che a sua volta è collegato a sistemi
meccanici, che possono servire per macinare il grano o per pompare l'acqua, o a
un aerogeneratore, che trasforma l'energia meccanica in elettrica.
L'energia eolica è una fra le più antiche forme di energia: i persiani
utilizzavano turbine eoliche ad asse verticale già nel VII secolo: servivano a
irrigare i terreni coltivati e a macinare il grano. In origine, la ruota che
sosteneva le pale dell'elica era orizzontale, fissata su un albero verticale. Il
sistema, benché poco efficace, si diffuse in Cina e in gran parte dell'Oriente,
e apparve in Europa, inizialmente in Francia e in Inghilterra, all'inizio del
XII secolo.
MULINI
A VENTO
I mulini a vento si sono diffusi in Europa durante il XIV secolo, innanzitutto
nei Paesi Bassi. Si componevano di una torre in pietra, sormontata da un tetto
rotante in legno, che sosteneva l'albero e la parte superiore del sistema a
ingranaggi del mulino. Dal tetto fuoriusciva un albero orizzontale, sul quale
era fissata una grande elica, composta da quattro o otto pale. I sostegni in
legno delle ali erano generalmente ricoperti in tela, o forniti di banderuole in
legno. La potenza dell'albero rotante era trasmessa da un sistema di ingranaggi
e di alberi secondari alla macina, che si trovava ai piedi della costruzione.
Le ali a ventaglio furono una
delle prime migliorie apportate ai mulini a vento, di modo che la superficie
delle pale si trovasse sempre sotto vento. Verso la fine del Settecento si
diffuse l'uso di ricoprire le pale con delle alette in legno, la cui apertura
poteva essere comandata automaticamente o manualmente: in questo modo, la
velocità di rotazione del rotore veniva resa quasi indipendente dalla velocità
del vento. Uno dei miglioramenti introdotti in tempi più moderni fu un sistema
di frenaggio per arrestare la rotazione delle pale.
LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Le turbine eoliche iniziarono a essere utilizzate per la produzione di
elettricità verso la fine del XIX secolo, in Danimarca, dove sono ancora oggi
largamente diffuse: funzionavano da piccoli generatori per fornire elettricità
a ristrette comunità rurali. Negli anni Trenta, con la diffusione delle linee
elettriche di trasporto, furono costruite turbine di potenza maggiore, che
potevano rifornire di energia zone più vaste.
Le macchine più diffuse erano quelle ad asse verticale; rivelatesi poco efficaci, vennero gradualmente soppiantate da quelle ad asse orizzontale. Recentemente tuttavia il sistema ad asse verticale è stato ripreso e perfezionato, ed è oggi utilizzato per turbine che producono una potenza elettrica inferiore a 50 kW.
AEROGENERATORI
I moderni aerogeneratori sono basati sullo stesso principio dei motori eolici
del passato, ovvero sullo sfruttamento dell'energia cinetica del vento per far
girare le pale di un rotore, secondo le leggi dell'aerodinamica, ma le loro
caratteristiche costruttive, e quindi il loro aspetto esteriore, ne differiscono
sensibilmente.
I due tipi principali di aeromotore si distinguono per la direzione dell'asse
del rotore, che può essere orizzontale o verticale. Quelli ad asse orizzontale,
che somigliano di più ai tradizionali mulini a vento, sono sistemati alla
sommità di un'alta torre e da lì azionano, mediante una trasmissione a ruote
dentate, l'albero del generatore di corrente collocato nell'interno, a livello
del terreno. Il diametro del rotore, generalmente a tre pale profilate come
quelle di un'elica aerea, può variare da poco più di un metro a cinque metri.
In alcuni modelli, il passo delle pale può essere variato per controllare la
velocità di rotazione, fino all'arresto del rotore in caso di vento eccessivo.
Un sistema direzionale che sfrutta il principio della banderuola mantiene
controvento il piano del rotore.
 Di
regola, i moderni aerogeneratori entrano in azione quando la velocità del vento
si avvicina ai 20 km/h, esprimono il massimo rendimento fra 40 e 50 km/h, e si
disattivano intorno ai 110 km/h. Il problema maggiore che deve affrontare la
produzione di energia eolica, infatti, è la naturale incostanza dei venti, che
si traduce in un funzionamento discontinuo degli aerogeneratori. Per questo
motivo, sono ritenute adatte all'installazione di aerogeneratori soltanto le
località caratterizzate da una velocità media annua del vento di almeno 21
km/h.
Di
regola, i moderni aerogeneratori entrano in azione quando la velocità del vento
si avvicina ai 20 km/h, esprimono il massimo rendimento fra 40 e 50 km/h, e si
disattivano intorno ai 110 km/h. Il problema maggiore che deve affrontare la
produzione di energia eolica, infatti, è la naturale incostanza dei venti, che
si traduce in un funzionamento discontinuo degli aerogeneratori. Per questo
motivo, sono ritenute adatte all'installazione di aerogeneratori soltanto le
località caratterizzate da una velocità media annua del vento di almeno 21
km/h.
Più efficienti, perché potenziano l'energia del vento e quindi sviluppano una
potenza maggiore, sono gli aeromotori ad asse verticale. Sono costituiti da un
involucro cilindrico fisso, percorso da fessure longitudinali, attraverso le
quali passa il flusso d'aria, e da un rotore coassiale con il generatore di
corrente. Le fessure sono accoppiate ad alette orientabili che regolano il
flusso d'aria, aprendosi solo dalla parte da cui soffia il vento.
L'energia eolica rappresenta
una valida alternativa alle fonti non rinnovabili, ad esempio il petrolio, e
soprattutto non produce inquinamento ambientale.
LE
CENTRALI EOLICHE
Il 2% dell'attuale produzione di energia elettrica della Danimarca proviene da
aerogeneratori, e lo stesso vale per la California. Le pochissime centrali
eoliche italiane generano una potenza pari a circa 50 MW, una minima parte dei
3000 MW installati a tutt'oggi nel mondo. Nei prossimi anni, la produzione di
energia elettrica dal vento in Italia dovrebbe salire a 400 MW, ottenuti da
installazioni a opera dell'ENEL, cui dovrebbe sommarsi una quantità analoga di
potenza prodotta con installazioni private. Gli esperti stimano che, alla metà
del XXI secolo, oltre il 10% dell'energia elettrica prodotta nel mondo sarà
ottenuta da aerogeneratori.
L’ENERGIA DELLE MAREE
Fenomeno ciclico
 E' caratterizzato dal periodico oscillare del
livello marino con alternanza di flusso l'alta
marea e di riflusso, la bassa marea.
L'ampiezza delle maree è poco rilevante in mare aperto, mentre assume valori
anche notevoli sulle coste oceaniche.
E' caratterizzato dal periodico oscillare del
livello marino con alternanza di flusso l'alta
marea e di riflusso, la bassa marea.
L'ampiezza delle maree è poco rilevante in mare aperto, mentre assume valori
anche notevoli sulle coste oceaniche.
L'ampiezza delle maree
Questa è legata al diverso profilo delle coste e
alla presenza di fondali più o meno profondi. In prossimità di golfi lunghi e
stetti, la massa d'acqua che avanza, subisce un rigonfiamento per la
compressione determinata dalla presenza di fondi meno profondi e di coste che si
restringono progressivamente.
Le causeL'attrazione che i corpi celesti esercitano sulla
Terra e la forza centrifuga, dovuta al moto di rotazione del sistema Terra-Luna,
sono i fattori più significativi che determinano il periodico oscillare delle
acque. L'attrazione gravitazionale fa sì che le masse d'acqua terrestri siano
attratte dal Sole e dalla Luna. Questo spiega però solo un flusso e un solo
riflusso al giorno, l'altra onda di marea è determinata dalla forza centrifuga,
causata dalla rotazione del sistema Terra-Luna che agisce sulla massa fluida.
Quindi, se abbiamo alta marea in un particolare punto del globo terrestre,
abbiamo alta marea anche al suo antipodo.
Maree vive e morte
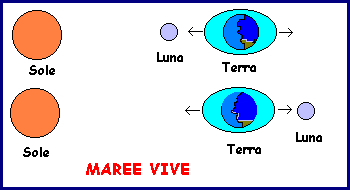 L'ampiezza delle maree è causata in maggior modo dalla Luna, infatti essa
esercita un'attrazione tre volte superiore a quella esercitata dal Sole.
L'ampiezza delle maree è causata in maggior modo dalla Luna, infatti essa
esercita un'attrazione tre volte superiore a quella esercitata dal Sole.
Le maree vive ci sono quando il Sole e la Luna sono in fase di congiunzione o di
opposizione, quindi sommano la loro forza d'attrazione e si hanno maree di
massima ampiezza.
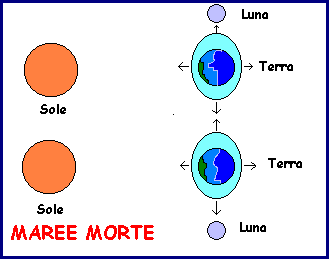 Le maree morte avvengono quando la Luna e il
Sole sono in quadratura e formano con la Terra un angolo di 90°; le loro azioni
attrattive si contrastano a vicenda e si hanno maree più deboli.
Le maree morte avvengono quando la Luna e il
Sole sono in quadratura e formano con la Terra un angolo di 90°; le loro azioni
attrattive si contrastano a vicenda e si hanno maree più deboli.
L’ENERGIA
DELLE MAREE:
Già nell’antichità si cercò di sfruttare questo tipo di energia, mediante
la costruzione di "mulini a marea". L’acqua veniva raccolta, durante
il flusso, in un piccolo bacino, che veniva in seguito chiuso con una paratia.
Al momento del deflusso l’acqua veniva convogliata attraverso un canale verso
una ruota che muoveva una macina. Oggi esistono diversi progetti di sfruttamento
delle maree, che comportano metodi diversi di sfruttamento dell’energia:
§
sollevamento
di un peso in contrapposizione alla forza di gravità;
§
compressione
dell’aria;
§
movimento
di ruote a pale;
§
riempimento
di bacini e successivo svuotamento immesso in turbine.
Quest’ultimo sembra dare i migliori risultati, sul
reale impiego. Ma il problema più importante resta comunque, quello delle maree
che pur seguendo le fasi lunari e solari (in un certo senso prevedibili) non
sempre coincidono con la richiesta i tempi di produzione. Infatti nei giorni di
assenza di movimento d’acqua la produzione di elettricità cesserebbe. In
Francia nei pressi di Saint Malo esiste un grosso impianto di questo genere.
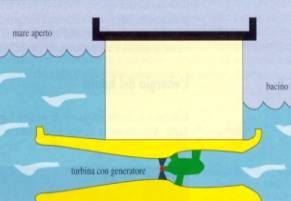 L’ENERGIA
DEL MOTO ONDOSO: Potenzialmente l’energia delle onde potrebbe contribuire
in modo significativo al fabbisogno di energia, essa è infatti una valida
sorgente di energia soprattutto nei paesi prospicienti all’oceano. In
Inghilterra sono stati brevettati oltre 350 progetti per l’estrazione
dell’energia dalle onde il "Braccio Galleggiante o Anatra" e quello
delle "Pompe a Stantuffo situate su zattere galleggianti" sino ad oggi
sono i più efficaci. E’ necessario quindi studiare nuovi progetti per rendere
sfruttabile questa significativa fonte di energia.
L’ENERGIA
DEL MOTO ONDOSO: Potenzialmente l’energia delle onde potrebbe contribuire
in modo significativo al fabbisogno di energia, essa è infatti una valida
sorgente di energia soprattutto nei paesi prospicienti all’oceano. In
Inghilterra sono stati brevettati oltre 350 progetti per l’estrazione
dell’energia dalle onde il "Braccio Galleggiante o Anatra" e quello
delle "Pompe a Stantuffo situate su zattere galleggianti" sino ad oggi
sono i più efficaci. E’ necessario quindi studiare nuovi progetti per rendere
sfruttabile questa significativa fonte di energia.
L'immensa riserva energetica offerta dal mare (oltre
il 70% della superficie terrestre è occupata da distese oceaniche con una
profondità media di 4000 m) si presta ad essere sfruttata principalmente in
diversi modi. Infatti oltre al calore dovuto al gradiente termico (differenza di
temperatura tra due punti), il mare possiede energia cinetica per la presenza di
correnti marine, delle onde e delle maree. Là dove c'è un'ampia escursione tra
alta e bassa marea è possibile ipotizzare la costruzione di una centrale
maremotrice. Scegliendo opportunamente il luogo, in modo da avere un ampio
bacino e maree di ampiezza di qualche metro è possibile utilizzare questa
energia di movimento che viene fornita gratis. Sulle coste del Canada, o su
quelle affacciate sul canale della Manica si raggiunge un dislivello di marea
che raggiunge gli 8-15 m; invece nel mediterraneo le escursioni di marea
superano appena i 50 cm. In generale lo sfruttamento delle maree per produrre
energia elettrica è poco efficace; finora sono stati costruiti due soli
impianti di questo tipo: il più importante si trova sull'estuario della Rance
in Bretagna (Francia), e ha una potenza di 240 MW, l'altro è in Russia.
L’ acqua affluisce e defluisce in un bacino di alcuni chilometri
quadrati, passando attraverso una serie di tunnel nei quali, acquistando velocità
fa girare delle turbine collegate a generatori (alternatori).
Durante la bassa marea l'acqua del bacino defluisce verso il mare aperto,
mettendo in rotazione la turbina; quando il livello del mare comincia a salire e
l'onda di marea è sufficientemente alta si fa fluire l'acqua del mare nel
bacino e, la turbina si mette nuovamente in rotazione. Una particolarità di
questo sistema è la reversibilità delle turbine che perciò possono funzionare
sia al crescere che al calare della marea.
Il principio di funzionamento delle centrali
maremotrici è comunque molto simile a quello quelle delle
centrali idroelettriche.
ENERGIA
DA BIOMASSE
Le biomasse sono masse di materia organica; attraverso la fermentazione
possono diventare combustibili utili, offrendo all’uomo un’importante fonte
di energia rinnovabile. In base ai materiali adoperati si differenziano il tipo
di processo seguito e il tipo di combustione ottenuta.
 I prodotti animali o vegetali possono essere utilizzati per produrre
energia, sia per combustione diretta come si fa bruciando la legna degli alberi,
sia indirettamente, mediante particolari processi di fermentazione o di
"digestione" anaerobica. Il principio attraverso il quale l'energia
raggiante del Sole si trasforma in energia contenuta in masse biologiche, o
biomasse, è quello stesso che nel lontano passato è stato alla base della
produzione delle immense masse che attualmente costituiscono i combustibili
fossili. Per quanto riguarda la produzione di biomasse, la conversione e la
fissazione dell'energia solare avvengono in natura attraverso un processo, la
fotosintesi, che, utilizzando l'energia dei fotoni solari, trasforma negli
organismi vegetali acqua e anidride carbonica in ossigeno e materiale organico
(combustibile) ad alto contenuto energetico. Per quanto riguarda l'utilizzo
delle biomasse, esiste una ricca serie di vegetali che, per fermentazione e
distillazione, possono dar luogo a gas e etanolo. Per esempio, la barbabietola o
la canna da zucchero forniscono alcol per fermentazione; i rifiuti animali e il
giacinto d'acqua possono fornire biogas (metano) sottoponendoli a fermentazione
mediante particolari microrganismi. La coltivazione intensiva di specie vegetali
a questo scopo è già stata intrapresa in Brasile in modo da produrre alcol da
miscelare alla benzina come carburante per le auto. In Italia, senza introdurre
squilibri nel campo agricolo, è stato possibile estendere la coltura della
barbabietola su una nuova superficie di 350.000 ettari in modo da ottenere
900.000 t di etanolo l'anno. Utilizzando poi insieme tutte le altre fonti
possibili, tra le quali i rifiuti urbani, si può arrivare a 2.300.000 t di
alcol all'anno, cifra che può essere largamente superata utilizzando le
sovrapproduzioni di uva e di frutta oggi destinate al macero.
I prodotti animali o vegetali possono essere utilizzati per produrre
energia, sia per combustione diretta come si fa bruciando la legna degli alberi,
sia indirettamente, mediante particolari processi di fermentazione o di
"digestione" anaerobica. Il principio attraverso il quale l'energia
raggiante del Sole si trasforma in energia contenuta in masse biologiche, o
biomasse, è quello stesso che nel lontano passato è stato alla base della
produzione delle immense masse che attualmente costituiscono i combustibili
fossili. Per quanto riguarda la produzione di biomasse, la conversione e la
fissazione dell'energia solare avvengono in natura attraverso un processo, la
fotosintesi, che, utilizzando l'energia dei fotoni solari, trasforma negli
organismi vegetali acqua e anidride carbonica in ossigeno e materiale organico
(combustibile) ad alto contenuto energetico. Per quanto riguarda l'utilizzo
delle biomasse, esiste una ricca serie di vegetali che, per fermentazione e
distillazione, possono dar luogo a gas e etanolo. Per esempio, la barbabietola o
la canna da zucchero forniscono alcol per fermentazione; i rifiuti animali e il
giacinto d'acqua possono fornire biogas (metano) sottoponendoli a fermentazione
mediante particolari microrganismi. La coltivazione intensiva di specie vegetali
a questo scopo è già stata intrapresa in Brasile in modo da produrre alcol da
miscelare alla benzina come carburante per le auto. In Italia, senza introdurre
squilibri nel campo agricolo, è stato possibile estendere la coltura della
barbabietola su una nuova superficie di 350.000 ettari in modo da ottenere
900.000 t di etanolo l'anno. Utilizzando poi insieme tutte le altre fonti
possibili, tra le quali i rifiuti urbani, si può arrivare a 2.300.000 t di
alcol all'anno, cifra che può essere largamente superata utilizzando le
sovrapproduzioni di uva e di frutta oggi destinate al macero.
Termodistruzione: l'energia che nasce dai rifiuti
 La produzione di rifiuti urbani in Italia è
cresciuta, dal 1994 ad oggi, del 3% in peso e del 4% in volume e tutto fa
pensare che questo trend non cambierà in modo sostanziale nei prossimi anni.
Con il Decreto Ronchi è stato introdotto il modello di gestione integrata che
tra le altre cose si pone come obiettivo il recupero attraverso il reimpiego ed
il riciclaggio allo scopo di ottenere materia prima dai rifiuti e utilizzazione
di questi come combustibile per produrre energia. Purtroppo queste intenzioni
sono rimaste solo sulla carta. La maggior parte dei rifiuti urbani (85%) sono
collocati in discarica, l'aliquota di rifiuto che viene riciclata o riusata
rimane sempre molto bassa ed la quantità che è termodistrutta è irrisoria.
Tutto ciò è derivato dalla arretratezza del sistema nazionale di gestione dei
rifiuti, dall'insufficienza dell'impiantistica di trattamento, recupero e
smaltimento. Per uscire da una situazione di continua emergenza e per una
corretta gestione del "problema rifiuti" la via obbligata è la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento termico ed il sostanziale
incremento della percentuale di rifiuti da avviare al recupero energetico.
L'Italia, a tutt'oggi, nel campo della termodistruzione è il fanalino di coda
rispetto agli altri paesi industrializzati, sia come numero di impianti
installati che come potenzialità. Infatti, la percentuale di rifiuti urbani
incenerita in Italia rispetto agli altri paesi industrializzati é nettamente
inferiore. Questo perché la frazione più importante dei rifiuti finisce in
discarica. Dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale non esistono
motivazioni che possano contrastare lo sviluppo di tale tecnologia di
smaltimento. Le elevate performances del processo di combustione e l'affidabilità
che le tecnologie di depurazione dei fumi hanno raggiunto in questi ultimi anni,
fanno di questo tipo di tecnologia una sicura scelta dal punto di vista
ambientale ed economico. Infatti tale tecnica di smaltimento può centrare
alcuni importanti obiettivi tra cui: a) elevata riduzione in volume e in peso
del rifiuto; b) detossificazione del rifiuto; c) possibilità di recupero di
energia elettrica e/o termica. Con il solo processo di combustione, infatti, il
volume ed il peso dei rifiuti possono essere rispettivamente ridotti al 10% e
30% di quelli iniziali. Inoltre, si pensi, che da una tonnellata di rifiuti si
può ricavare la stessa energia di 200 Kg di petrolio. Non è una potenzialità
di poco conto, se si considera che i circa 27 milioni di ton/anno di rifiuti
urbani prodotti in Italia potrebbero sostituire fino a 5 milioni di tonnellate
di petrolio, per un valore economico di circa 3000-3500 miliardi di lire.
La produzione di rifiuti urbani in Italia è
cresciuta, dal 1994 ad oggi, del 3% in peso e del 4% in volume e tutto fa
pensare che questo trend non cambierà in modo sostanziale nei prossimi anni.
Con il Decreto Ronchi è stato introdotto il modello di gestione integrata che
tra le altre cose si pone come obiettivo il recupero attraverso il reimpiego ed
il riciclaggio allo scopo di ottenere materia prima dai rifiuti e utilizzazione
di questi come combustibile per produrre energia. Purtroppo queste intenzioni
sono rimaste solo sulla carta. La maggior parte dei rifiuti urbani (85%) sono
collocati in discarica, l'aliquota di rifiuto che viene riciclata o riusata
rimane sempre molto bassa ed la quantità che è termodistrutta è irrisoria.
Tutto ciò è derivato dalla arretratezza del sistema nazionale di gestione dei
rifiuti, dall'insufficienza dell'impiantistica di trattamento, recupero e
smaltimento. Per uscire da una situazione di continua emergenza e per una
corretta gestione del "problema rifiuti" la via obbligata è la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento termico ed il sostanziale
incremento della percentuale di rifiuti da avviare al recupero energetico.
L'Italia, a tutt'oggi, nel campo della termodistruzione è il fanalino di coda
rispetto agli altri paesi industrializzati, sia come numero di impianti
installati che come potenzialità. Infatti, la percentuale di rifiuti urbani
incenerita in Italia rispetto agli altri paesi industrializzati é nettamente
inferiore. Questo perché la frazione più importante dei rifiuti finisce in
discarica. Dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale non esistono
motivazioni che possano contrastare lo sviluppo di tale tecnologia di
smaltimento. Le elevate performances del processo di combustione e l'affidabilità
che le tecnologie di depurazione dei fumi hanno raggiunto in questi ultimi anni,
fanno di questo tipo di tecnologia una sicura scelta dal punto di vista
ambientale ed economico. Infatti tale tecnica di smaltimento può centrare
alcuni importanti obiettivi tra cui: a) elevata riduzione in volume e in peso
del rifiuto; b) detossificazione del rifiuto; c) possibilità di recupero di
energia elettrica e/o termica. Con il solo processo di combustione, infatti, il
volume ed il peso dei rifiuti possono essere rispettivamente ridotti al 10% e
30% di quelli iniziali. Inoltre, si pensi, che da una tonnellata di rifiuti si
può ricavare la stessa energia di 200 Kg di petrolio. Non è una potenzialità
di poco conto, se si considera che i circa 27 milioni di ton/anno di rifiuti
urbani prodotti in Italia potrebbero sostituire fino a 5 milioni di tonnellate
di petrolio, per un valore economico di circa 3000-3500 miliardi di lire.